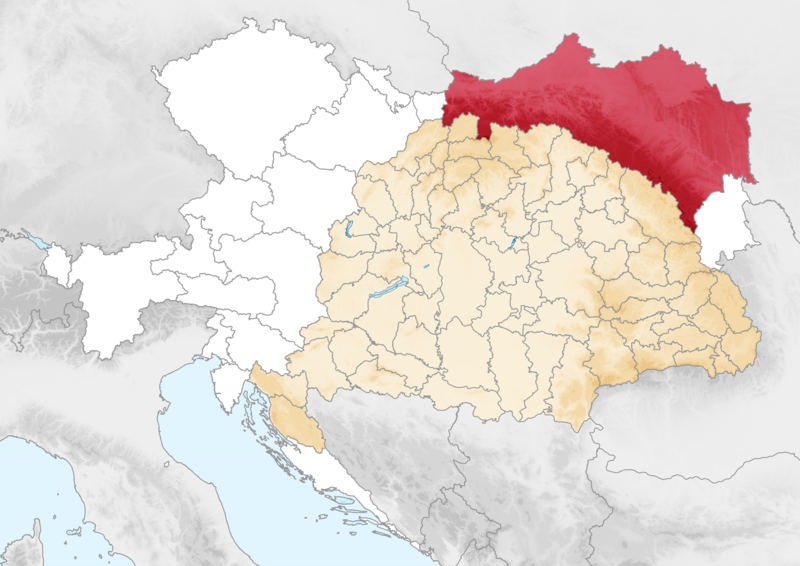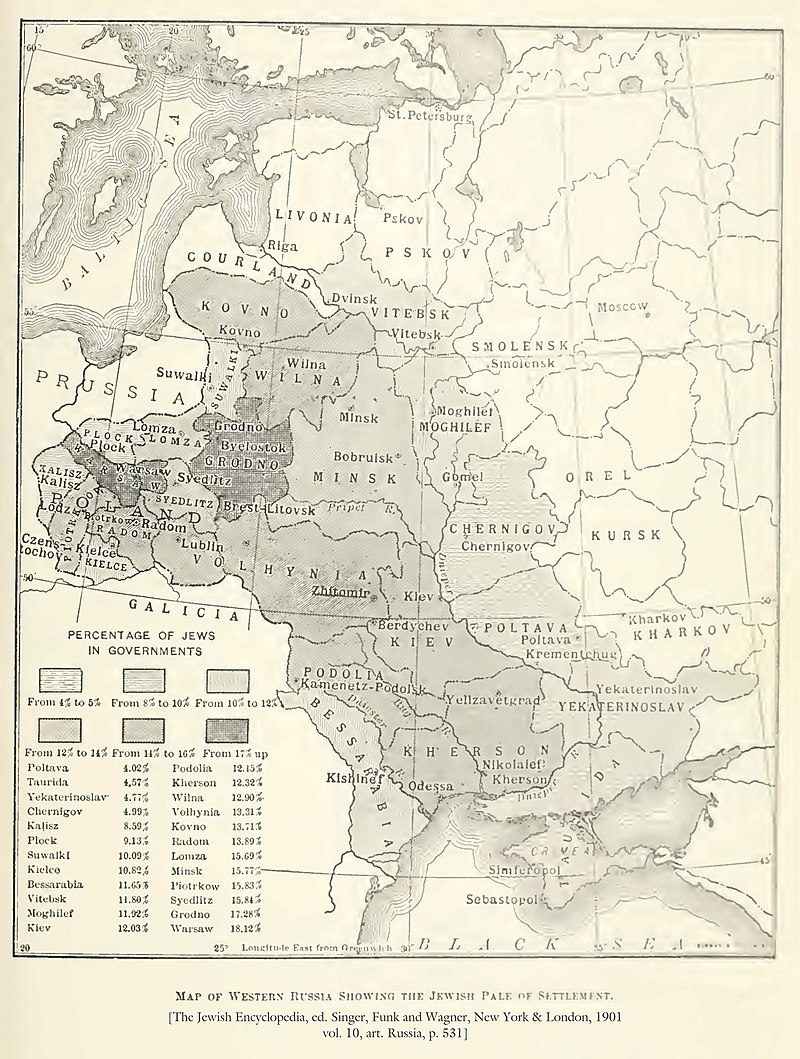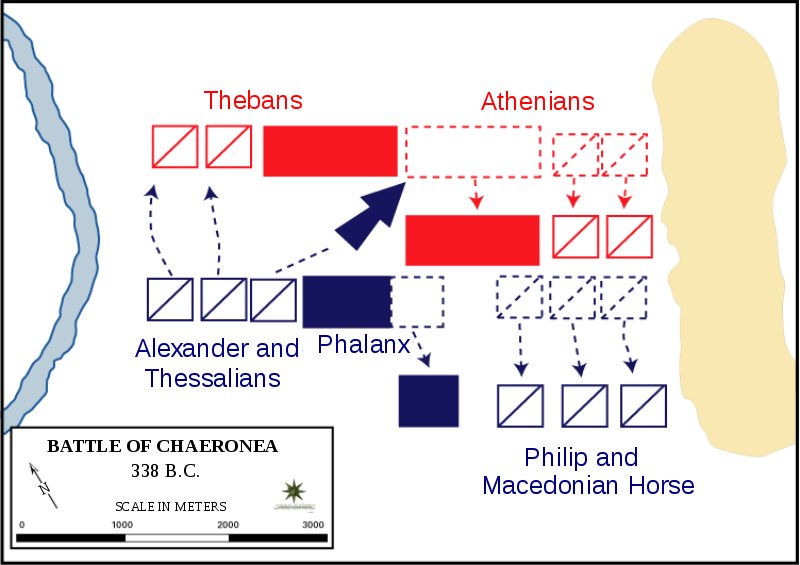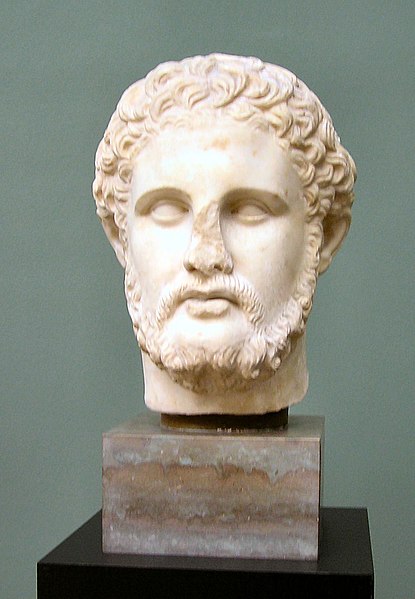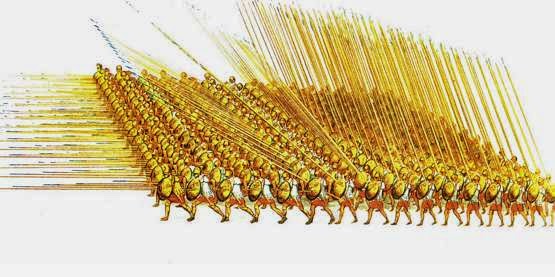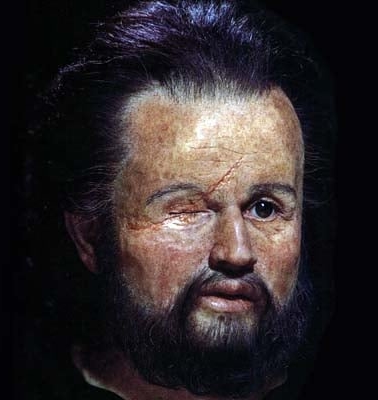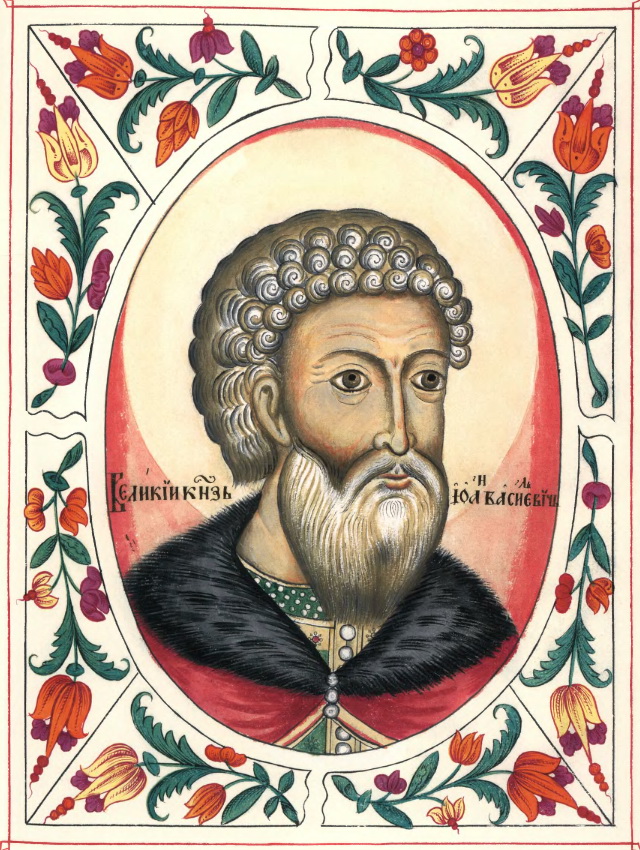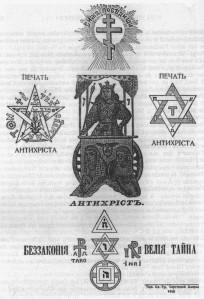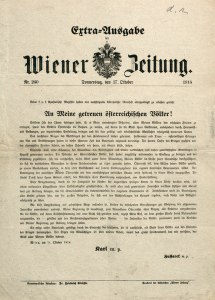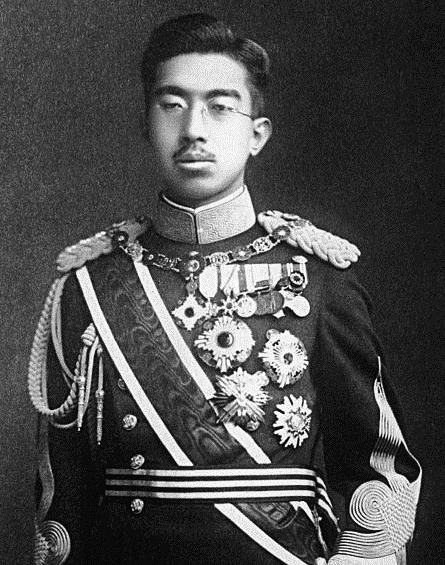
L’imperatore Hirohito Fonte Wikimedia Commons
Il periodo Shōwa (1926-1989), coincidente con il regno dell’imperatore Hirohito, è senza dubbio uno dei periodi più complessi — e quindi interessanti — della recente storia giapponese. Nel corso di questi oltre sei decenni, che diventano quasi sette se prendiamo in considerazione anche i cinque anni di reggenza in coda al periodo Taishō, il paese asiatico oscillò tra periodi di forte crescita e profonde crisi economiche, politiche e sociali, visse l’orrore di una peculiare forma di totalitarismo militarista e gli sconvolgimenti del secondo conflitto mondiale per poi risorgere, letteralmente, dalle proprie ceneri e diventare una delle maggiori economie. Va da sé che un periodo di questo tipo non può essere affrontato in maniera esaustiva in un singolo post, per cui in questa occasione mi limiterò a tracciare un quadro dei primi primi anni, a mio avviso fondamentali per comprendere la deriva totalitaria degli anni Trenta.
Hirohito divenne imperatore alla morte del padre, il 25 dicembre 1926, a soli venticinque anni. Le condizioni di salute sempre più precarie del suo predecessore, avevano però reso necessaria la sua nomina a reggente sin da novembre 1921: nonostante la giovane età, il nuovo sovrano aveva quindi già una solida esperienza di governo. Il suo carattere schivo ed una naturale tendenza all’isolamento lo rendevano incredibilmente adatto ad impersonare un sovrano divino, ma al tempo stesso gli impedivano di comprendere le condizioni di vita dei suoi sudditi. Questo, unito ad una certa ambiguità della carta costituzionale circa il ruolo imperiale nella struttura dello Stato, ebbe importanti conseguenze negli anni a venire.
L’economia giapponese aveva goduto di diversi benefici a partire dallo scoppio della Grande Guerra. L’industria chimica e pesante nipponica aveva approfittato del blocco navale ai danni degli Imperi Centrali per occupare le nicchie di mercato dei competitori tedeschi, mentre il comparto tessile era trainato dalla crescente domanda statunitense. Nel complesso la produzione industriale quintuplicò, mentre le esportazioni triplicarono.
Contestualmente la crescente offerta di posti di lavoro nelle fabbriche e nel terziario — è proprio in questo periodo che nasce la figura del salaryman — accelerò il processo di inurbamento iniziato durante la modernizzazione di epoca Meiji. Se nel 1895 soltanto il 12% dei giapponesi viveva in centri urbani con più di diecimila abitanti, a metà degli anni Trenta la percentuale era salita al 45%.
L’abbandono delle campagne era causato anche dalla stagnazione che faceva arrancare l’intero settore agricolo. Oltre ad una cronica mancanza di investimenti, in quanto i proprietari terrieri preferivano reinvestire le loro rendite nei ben più redditizi titoli finanziari, i fittavoli dovevano fronteggiare canoni di affitto elevatissimi: il sistema fiscale dell’epoca, infatti, penalizzava la proprietà fondiaria con imposte particolarmente salate ed i proprietari si rifacevano così sui contadini. Nonostante ciò per un certo periodo essi poterono beneficiare di un forte rincaro del riso: il prezzo all’ingrosso per koku — il quantitativo di riso necessario a nutrire una persona per un anno, circa centocinquanta chili — triplicò, passando da 14 a 44 yen.

Yokohama dopo il terremoto. Fonte: Yokohama Central Library via Wikimedia Commons
La fine del conflitto pose fine a questa congiuntura favorevole. A partire dal 1920 si susseguirono una serie di crisi economiche e finanziarie, la più grave delle quali si verificò nel 1927. Il forte indebitamento delle aziende, aggravato dal devastante terremoto del Kantō (1 settembre 1923) che colpì l’area con la più alta concentrazione di attività produttive del paese, aveva lasciato scoperti i libri contabili di numerosi istituti bancari. Per evitare il collasso finanziario il governo autorizzò la Banca del Giappone a farsi carico delle cambiali relative ad attività colpite dal sisma, impegnandosi a risarcire eventuali perdite fino ad un massimo di 100 milioni di yen. Le banche, tuttavia, ne approfittarono per inserire anche altre cambiali: entro la fine dell’anno fiscale le richieste di pagamento raggiunsero la stratosferica cifra di 430 milioni, pari ad un terzo dell’intero bilancio statale. In particolare la sola Banca di Taiwan risultava scoperta per 100 milioni.
Nel marzo del 1927 risultavano ancora insoluti importi per circa 270 milioni. Il governo tentò alcune azioni per concludere definitivamente la faccenda, ma la rivalità tra i partiti trascinò la discussione troppo a lungo, contribuendo a far scoppiare il panico tra i risparmiatori. La corsa agli sportelli causò il fallimento di decine di istituti bancari di piccole e medie dimensioni. Il numero di banche private attive sul territorio nipponico passò da 1417 a 779, con cinque istituti di credito a detenere da soli un quarto dell’intero capitale bancario del paese. Il potere economico finì quindi per concentrarsi nelle mani di un pugno di zaibatsu, i grandi conglomerati a guida familiare la cui attività ramificata toccava settori diversissimi tra loro, che iniziarono ad esercitare una crescente influenza sul potere politico.
Come se ciò non bastasse, sul finire del decennio il prezzo del riso subì un crollo, toccando nel 1930 il valore di 18 yen per koku. I fittavoli si trovarono in crescente difficoltà, ricorrendo in misura sempre maggiore all’indebitamento per far fronte all’affitto delle terre. È stato calcolato che tra 1926 e 1931 l’indice monetario rurale passò da 100 a 33, con un calo più che doppio rispetto ai redditi urbani. Detto in termini più prosaici, gli spettri della miseria e della fame aleggiavano sulle campagne.
La crisi economica ed una generalizzata sfiducia nei confronti della classe politica crearono le condizioni ideali al proliferare dell’estremismo politico. In particolare fu l’esercito, i cui ranghi erano composti soprattutto da uomini provenienti da ambienti rurali, a divenire catalizzatore del malcontento. Nel giugno 1928 si verificò il primo di una lunga serie di “incidenti” che videro coinvolti i militari. Alcuni elementi dell’armata del Kwantung, di stanza a Port Arthur, fecero esplodere il treno su cui viaggiava il signore della guerra cinese Zhang Zuolin. I cospiratori incolparono dell’accaduto dei banditi cinesi, nella speranza di sfruttare l’accaduto come giustificazione per un intervento armato in Manciuria. Il complotto venne smascherato grazie all’intervento di una fazione più moderata, ma i responsabili furono puniti solo il modo simbolico: la mancanza di provvedimenti disciplinari fu gravida di conseguenze negli anni a venire.
Più in generale gli ambienti reazionari nipponici vedevano il paese ed i suoi valori tradizionali minacciati tanto dalla Russia bolscevica quanto dall’asse anglo-americano. Emblematici in questo senso gli scritti di Konoe Funimaro, che invitava i contemporanei a diffidare dei valori democratici e umanitari portati avanti dalle potenze occidentali: questi altro non erano che pretesti per portare avanti tendenze egemoniche e per negare al Giappone il proprio ruolo di potenza asiatica. Si venne quindi a creare una pericolosa saldatura tra gli ambienti nazionalisti e quelli delle organizzazioni panasiatiste più radicali, che da tempo accarezzavano l’idea di una decisa espansione territoriale sul continente. Altrettanto interessanti e forse anche più influenti furono le opere di Kita Ikki. Costui fece propri diversi argomenti del discorso marxista, come la critica al capitalismo, rigettando però il concetto di lotta di classe. Ad essa contrapponeva la necessità di ricompattare la nazione sotto la guida dell’imperatore che, come centro spirituale, avrebbe guidato il Giappone nel compimento della sua missione storica di liberatore dei popoli asiatici oppressi dal giogo dell’imperialismo occidentale.

Ōsugi Sakae nel 1920. Fonte Wikimedia Commos
A sinistra la situazione era molto più frammentaria. Il movimento anarchico aveva subito un duro colpo dopo il terremoto del Kantō, con l’uccisione da parte della polizia del leader anarco-sindacalista Ōsugi Sakae e della sua compagna Noe Itō. La repressione colpì anche i socialisti, sebbene le correnti moderate furono relativamente tollerate, ed i comunisti. Questi ultimi si erano dotati di una struttura clandestina e operavano seguendo una strategia che ricalcava quella del “fronte unito” adottata dal Partito Comunista Cinese: posto che il Giappone si trovava ancora in condizioni semifeudali, occorreva collaborare con tutte le forze progressiste al fine di lanciare una rivoluzione borghese come primo passo verso la costruzione del socialismo. Anche per questo, in occasione delle prime elezioni a suffragio universale maschile (1925), i comunisti appoggiarono il Rōnōtō, il più radicale tra i partiti proletari. Le autorità reagirono mettendo al bando il Rōnōtō e lanciando una vasta campagna di arresti ai danni della rete comunista, tanto che entro il 1929 quasi tutti i dirigenti finirono in galera.
In risposta ai fermenti dell’estrema destra e dell’estrema sinistra, il Giappone si dotò di un crescente arsenale di strumenti repressivi. Sin dal 1925 era stata approvata una legge, applicata per la prima volta proprio contro i comunisti, che puniva col carcere il promuovere qualsiasi cambiamento nella struttura politica nazionale. Poco dopo un decreto imperiale d’urgenza modificò il testo, introducendo la pena capitale nei casi più gravi. A partire dal 1928 venne rafforzato anche l’apparato investigativo, con l’istituzione in ogni prefettura di una sezione della Polizia superiore speciale (Tokkō), il cui compito era proprio quello di indagare sulle attività sovversive. In contemporanea venne creata la figura dei shisō kenji, i “procuratori del pensiero” specializzati nei reati ideologici.
Alla repressione si affiancò una capillare struttura di indottrinamento. Nel 1925 era stato approvato un programma di addestramento militare obbligatorio per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, mentre l’anno successivo era stata creata una rete di “centri di addestramento della gioventù” aperti a tutti coloro in possesso della sola licenza elementare: oltre alle nozioni militari ai cittadini venivano impartire lezioni per “elevare” le loro capacità. Analogamente si istituirono federazioni giovanili sia maschili che femminili. Lo scopo, piuttosto evidente, era quello di imporre la propria egemonia culturale e dotarsi di uno strumento efficace per mobilitare la popolazione: questi elementi giocarono un ruolo fondamentale negli anni Trenta e ancora di più nel decennio successivo; la fragile democrazia Taishō aveva ormai i giorni contati, ma di questo parlerò un’altra volta.
BIBLIOGRAFIA
K. G. Henshall, Storia del Giappone, Milano, Arnoldo Mondadori, 2016
R. H. P. Mason, J. G. Caiger, A History of Japan, Rutland, Tuttle Publishing, 1997
A. Revelant, Il Giappone moderno dall’Ottocento al 1945, Torino, Einaudi, 2018